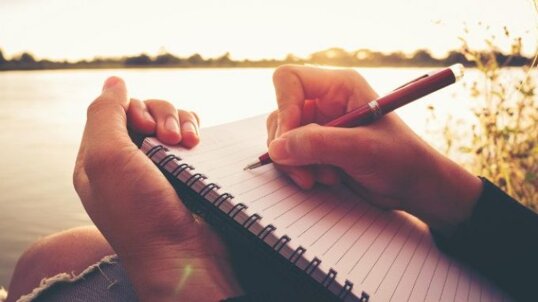Paura, curiosità e bisogno di capire il male. Il true crime è ovunque: serie TV, podcast, documentari, speciali su YouTube.
Ogni settimana una nuova storia di delitto, mistero e indagine cattura milioni di spettatori.
Ma perché? Perché proviamo un’attrazione così potente verso il lato oscuro della realtà?
Noi psicologi lo sappiamo bene: la curiosità verso il pericolo è una forma di apprendimento.
Quando ascoltiamo una storia di omicidio o seguiamo un’inchiesta giudiziaria, la nostra mente si mette in moto. Cerchiamo schemi, motivazioni, segnali nascosti.
È un modo per capire l’imprevedibile e, in qualche modo, prepararci ad affrontarlo. Guardare il male da lontano ci fa sentire al sicuro. Dietro il fascino del true crime si nasconde un desiderio antico: il controllo.
Seguendo un caso, interpretando prove e testimonianze, ci illudiamo di poter capire la violenza e quindi di tenerla a bada. Molte persone dichiarano apertamente di appassionarsi al genere proprio per imparare a riconoscere segnali di pericolo nelle relazioni o negli ambienti sociali. Il true crime non parla solo di assassini. Parla di vittime, di famiglie, di comunità ferite.
Molte persone si avvicinano a questo genere spinte da empatia e senso di giustizia.
Ogni volta che la verità tarda ad arrivare o la giustizia sembra vacillare, sentiamo il bisogno di capire di più, di “esserci”. In un certo senso, consumare queste storie ci permette di condividere il dolore delle vittime e trasformarlo in consapevolezza.
E poi ci sono loro, i casi che non trovano mai una fine, che ci tengono svegli la notte, che accendono forum e podcast, che fanno discutere anche dopo decenni.
Da un punto di vista psicologico, la loro forza sta nel bisogno di chiusura cognitiva: la mente umana non sopporta il vuoto. Quando una storia resta sospesa, continuiamo a cercare risposte.
Un esempio emblematico è il caso di Chiara Poggi, la giovane di Garlasco uccisa nel 2007.
Nonostante le condanne definitive inflitte ad Alberto Stasi, molti continuano a interrogarsi sulla dinamica e sulle prove. Il processo si è concluso, ma nella percezione collettiva qualcosa resta aperto. È il potere (e il paradosso) del true crime: quando la giustizia chiude un caso, ma la mente no.
Lo stesso vale per il delitto di Serena Mollicone ad Arce, risolto dopo oltre vent’anni, o per il caso del Mostro di Firenze, ancora oggi fonte di nuove teorie e docufilm.
Attorno a questi misteri si formano vere e proprie comunità digitali di “investigatori amatoriali”, un fenomeno che mescola desiderio di giustizia, curiosità.
Ogni storia reale diventa racconto collettivo, un modo per elaborare paure e riflettere su come la società reagisce al male.
C’è però un rischio. L’esposizione costante a crimini e violenza può generare ansia, diffidenza, insonnia e aumentare la percezione che il mondo sia più pericoloso di quanto sia in realtà.
È la cosiddetta mean world syndrome: se vediamo solo male, iniziamo a credere che il male sia ovunque. La linea che separa curiosità e saturazione è sottile.
Per questo è importante consumare il true crime in modo consapevole, scegliendo contenuti che rispettino le vittime e non trasformino il dolore in spettacolo.
Forse è questo il vero motivo del nostro amore per il true crime: non tanto il desiderio di guardare il male, quanto quello di capirlo.
Il true crime può, quindi, diventare non solo intrattenimento, ma uno strumento per riflettere sulla nostra umanità, sulle nostre paure e sulla fragilità della verità. Vi ci riconoscete?
Dott.ssa Ylenia De Carlo